

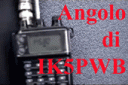
Categorie:
- Angolo di Clari (rss) (12)
- Angolo di IK5PWB (rss) (7)
- Angolo di Orsi e crocette (rss) (62)
- Album lavori a punto croce (rss) (50)
- Quadri a punto croce (rss) (14)
- Tombolo (rss) (3)
- Varie a punto croce (rss) (17)
- Album lavori con tecniche varie (rss) (20)
- Punto croce (rss) (38)
- Trine e merletti (rss) (2)
- Album lavori a punto croce (rss) (50)
- Angolo di Samy (rss) (25)
- Astro-Giove (rss) (11)
- Astro-Luna (rss) (29)
- Astro-Marte (rss) (3)
- Astro-Saturno (rss) (11)
- Astro-Sole (rss) (62)
- Astro-Venere (rss) (14)
- Astronautica (rss) (9)
- Astronomia (rss) (50)
- Attualità (rss) (27)
- Chiacchierino (rss) (26)
- Cucina (rss) (2)
- Fiori (rss) (6)
- I miei lavori (rss) (36)
- Libri (rss) (2)
- Luna (rss) (11)
- Maglia (rss) (8)
- Meteo cittadino (rss) (14)
- Natura (rss) (27)
- Per Clarissa (rss) (19)
- Per Samantha (rss) (23)
- Personali (rss) (242)
- Piccole cose (rss) (38)
- Punto croce (rss) (14)
- Racconti (rss) (6)
- Ricamo (rss) (9)
- Ricerca amici scomparsi (rss) (2)
- Ricette pasquali (rss) (1)
- Riciclaggio (rss) (5)
- Scuola di maglia (rss) (5)
- Uncinetto (rss) (12)
![]()
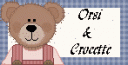

|
RICORDI
![]()
Blogroll
- Accademia delle stelle - Associazione culturale per la diffusione della scienza e dell'astronomia - a Roma
- Atlas Coelestis - Quando le mappe celesti erano arte...
- Il sito di Marco Meniero - Astronomia in fotografia e molto altro
- Unione Astrofili Italiani - La passione (per l'Astronomia), abita qui...
Meta:
-
"
"
- Login
- John Doe Blog
- XFN
- WP
La Pasqua
Pasqua (e Pasquale) è un nome dato tradizionalmente ai bambini nati il giorno di Pasqua. Deriva dal latino ecclesiastico Pascha, attraverso il greco Pascha, l’ebraico Pesah e l’aramaico Pisha. Deriverebbe in origine dall’ebraico “pasah”, passare oltre, ma sarebbe stato accostato per etimologia popolare con il tardo latino medioevale “pascua”, pascoli, prati.
Da Wikipedia
LA DATA DELLA PASQUA dal 1947 al 2042
quando sarà di nuovo Pasqua e il mio compleanno (se ci arrivo)
| 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 |
6 aprile 29 marzo 17 aprile 9 aprile 25 marzo 13 aprile 5 aprile 18 aprile 10 aprile 1 aprile 21 aprile 6 aprile 29 marzo 17 aprile 2 aprile 22 aprile 14 aprile 29 marzo 18 aprile 10 aprile 26 marzo 14 aprile 6 aprile 29 marzo |
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 |
11 aprile 2 aprile 22 aprile 14 aprile 30 marzo 18 aprile 10 aprile 26 marzo 15 aprile 6 aprile 19 aprile 11 aprile 3 aprile 22 aprile 7 aprile 30 marzo 19 aprile 3 aprile 26 marzo 15 aprile 31 marzo 19 aprile 11 aprile 3 aprile |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
16 aprile 7 aprile 30 marzo 12 aprile 4 aprile 23 aprile 15 aprile 31 marzo 20 aprile 11 aprile 27 marzo 16 aprile 8 aprile 23 marzo 12 aprile 4 aprile 24 aprile 8 aprile 31 marzo 20 aprile 5 aprile 27 marzo 16 aprile 1 aprile |
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 |
21 aprile 12 aprile 4 aprile 17 aprile 9 aprile 31 marzo 20 aprile 5 aprile 28 marzo 16 aprile 1 aprile 21 aprile 13 aprile 28 marzo 17 aprile 9 aprile 25 marzo 13 aprile 5 aprile 25 aprile 10 aprile 1 aprile 21 aprile 6 aprile |
La data della Pasqua ha costituito nei secoli un problema di non facile soluzione.
L’origine di questo problema risale ai primi secoli dopo la nascita del cristianesimo.
Premesse
Nei Vangeli si narra che Gesù e i discepoli consumarono l’Ultima Cena come pasto rituale secondo la legge mosaica, poi egli venne catturato, e il giorno dopo (Pesah),condannato a morte.
Dopo 3 giorni sarebbe avvenuta la Resurrezione.
Tutti e 4 i Vangeli pongono questo evento nel primo giorno della settimana ebraica, cioè il giorno che segue lo shabbath (il sabato), e nel terzo giorno dopo la crocifissione.
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé
gli aromi che avevano preparato. (Luca)
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino,
quand`era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. (Giovanni)
Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. (Marco)
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. (Matteo)
Gli evangelisti hanno quindi fissato la passione ad una data del mese lunare (Pesah viene celebrata la sera del 14° giorno del mese di Nissan che inizia con la prima luna nuova di primavera, quando si rende visibile il crescente lunare, - data che deriva dall’Antico Testamento - quindi in corrispondenza della Luna piena (14 giorni dopo).
Nei primi tempi la resurrezione veniva celebrata settimanalmente il giorno dopo il shabbath. Le prime testimonianze della celebrazione annuale risalgono alla fine del II secolo; la celebrazione avveniva il XIV giorno di Nissàn e la resurrezione 3 giorni dopo, senza tener conto di che giorno della settimana fosse.
Alcune comunità cristiane però sostenevano che la celebrazione dovesse essere vincolata al giorno della settimana dopo lo shabbath, quella che poi divenne il giorno del Signore: Dies dominica, domenica.
Quindi si faceva risalire la crocifissione al 6° giorno ebraico, (il venerdì) e 3 giorni dopo (venerdì incluso), la Resurrezione.
L’inizio del mese di Nissan veniva annunciato dalla Sinagoga quando davanti al Sinedrio (l’organo preposto all’emanazione delle leggi ed alla gestione della giustizia), si testimoniava che era stata avvistata la prima falce lunare di primavera, e questo causava una “dipendenza” della cristianità dalle autorità ebraiche
Le comunità cristiane poi erano ormai sparse in un’area molto vasta e c’erano a quei tempi difficoltà di comunicazione che impedivano che la celebrazione avvenisse nello stesso giorno, (anche le condizioni meteorologiche non erano uguali dappertutto, impedendo la visione del crescente lunare). Per rimarcare la differenza tra le due Pasque si doveva trovare un modo per stabilire l’inizio di Nissan indipendentemente dal calendario ebraico. Questo comportava il passaggio da un calendario lunisolare a uno soltanto solare come quello romano.C’era poi un altro problema, legato all’individuazione dell’Equinozio di primavera.
CALENDARIO GIULIANO
Nel mondo latino (vigente il calendario giuliano) la data era fissata al 25 marzo; nel mondo greco invece, veniva considerata più correttamente al 21 marzo.
La soluzione a questo problema fu raggiunta dopo secoli.
Una parte della comunità cristiana continuò a mantenere lo stretto legame con il XIV giorno di Nissàn, e si chiamarono quartodecimani, altri celebravano la Resurrezione la domenica e la crocifissione il venerdì, attenendosi soltanto al vincolo della Luna piena. Vittore, vescovo di Roma, verso la fine del II secolo decretò la soppressione del quartodecimanismo (ci fu persino una scomunica che poi venne ritirata) e fissò l’obbligo di celebrare la Pasqua di domenica attenendosi al vincolo del plenilunio e dell’equinozio: la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Per contrastare i quartodecimani occorreva trovare un modo di stabilire una data che avesse valenza per tutti i tempi a venire. L’osservazione del crescente lunare era un evento difficile da tenere in considerazione: oltre alle difficoltà già accennate su comunicazioni e condizioni meteorologiche, basarsi esclusivamente sui moti celesti avrebbe comportato grande competenza nell’astronomia e anche tavole aggiornate.
Bisognava trovare regole sicure che valessero anche per chi non avesse conoscenze astronomiche.
Il modo più sicuro era legarsi a cicli periodici nella relazione tra fasi lunari e data del calendario.
Alcune chiese nei primi secoli si basavano sul ciclo di 8 anni giuliani considerati corrispondenti a 99 cicli lunari. Questo ciclo (canone) però in 8 anni dà una differenza di un giorno e mezzo; in 30 anni sarebbero diventati 6 giorni di ritardo.
Un altro sistema adottato all’inizio del III secolo fu legato al ciclo di 84 anni giuliani considerati equivalenti a 1039 lunazioni. Questo metodo era senz’altro migliore (un ritardo di soli 1,3 giorni a fine del ciclo, e anche una corrispondenza numerica tra 84 e 28 (28 e’ divisore di 84), per il quale i giorni della settimana si ripetono nelle stesse date). L’anno conta 52 settimane più un giorno 52X7+1. Lo stesso giorno della settimana slitterebbe, l’anno successivo, di un giorno (es. se il primo dell’anno è un lunedì, l’anno seguente sarà un martedì, l’anno seguente un mercoledì, fino a completare in 7 anni il ciclo). Ma c’è di mezzo l’anno bisestile che arriva ogni IV anno; quindi, dopo l’anno bisestile, si slitta di due giorni. Il ciclo quindi si completa in 28 anni (28 è il mcm tra 7 e 4): questo ciclo si chiama ciclo solare e si riferisce non alla nostra stella ma al giorno del sole (domenica). Nel concilio di Nicea (325), fu deciso che la Pasqua dovesse avvenire “la domenica successiva alla Luna piena di primavera, cioè alla prima che cade dal giorno dell’Equinozio di primavera.
Non ci sono prove certe che nello stesso Concilio si sia presa la decisione di fissare al 21 marzo la data dell’Equinozio, (sistema già adottato dalla chiesa alessandrina). Solo dopo due secoli questa data venne osservata in tutta la cristianità.
Per avere delle tavole con le date della Pasqua valevoli per il futuro occorreva trovare un multiplo comune tra il ciclo solare, il ciclo delle fasi lunari e il ciclo dell’anno giuliano.
Questo ciclo era il ciclo di Metone (già conosciuto dai vescovi alessandrini, che però ne custodivano gelosamente la conoscenza, e fu adottato solo a partire dal V secolo.
METONE
Metone ateniese (V secolo a.C.) astronomo greco. Il ciclo metonico è noto anche come “anno di Metone” o “grande anno”. Periodo minimo di 19 anni che comprende un numero intero di anni solari –19 – e mesi lunari – 235 – con uno scarto di meno di due ore. All’interno di un ciclo si ripetono gli stessi fenomeni solari e lunari (come le eclissi).
Nel calendario giuliano ogni 19 anni si ripetono le date dei pleniluni. Basta conoscere il posto che un anno occupa nel ciclo di 19 anni per conoscere le date di tutti i pleniluni.
Nel calendario giuliano il periodo di ripetizione dello stesso ordine delle date di Pasqua è 19×28 = 532 anni.
Di queste tavole ne vennero stilate due: una dal vescovo alessandrino Teofilo e una dal suo successore Cirillo, per un totale di 5 cicli metonici 19×5=95 anni. Arriviamo al 531.
Nei primi decenni del VI secolo Dionigi il Piccolo fu incaricato di redigere nuove tavole per la data della Pasqua.
Fino ad allora le date venivano calcolate dalla fondazione di Roma (753 ab Urbe Condita) oppure, in ambito cristiano, dall’era dei martiri che cominciava dal primo anno dell’impero di Diocleziano (1037 a.U.c.), il grande persecutore. Dionigi non volle mantenere questo collegamento. Intanto fissò l’Incarnazione al 25 marzo e il Natale il 25 dicembre (nei tempi precedenti era dedicata alla festa del Sole rinascente (il dies natalis Solis invicti). L’anno successivo, (754) il 1 gennaio fu dichiarato anno 1 dell’era cristiana o volgare, (nobile lo era quella che contava dalla fondazione di Roma.)
La tavola di Dionigi copriva 95 anni dall’anno 532 d. C.. Assegnando il numero 1 all’1 a.C. presunta data della nascita di Cristo, (1…-1, manca lo zero) si poteva ottenere il numero d’oro di qualsiasi anno (M (anno) +1)/19. Se il resto fosse 0 si considera come numero d’oro il 19).
Siamo in pieno Medioevo, il progresso scientifico non ha fatto molti progressi . La maggior parte delle opere di scienza ellenistica sono andate perdute: gli Arabi sono intervenuti quando gran parte del sapere era ormai perduto. I centri più importanti della conoscenza divennero Bagdad e Cordova che possedeva una grande biblioteca e dove si traducevano opere greche in arabo. Dopo il Mille alcune di queste conoscenze cominciarono a filtrare dall’Islam verso il mondo cristiano.
A Toledo si ricominciò a tradurre i libri antichi in latino dal greco o dall’arabo. Nel 1175 per opera di Gherardo da Cremona, si ebbe la prima traduzione dall’arabo in latino dell’Almagesto di Tolomeo.
Le conoscenze astronomiche così acquisite resero evidenti alcuni errori che si erano consolidati negli anni e che occorreva correggere.
Nel 1252 un gruppo di 50 sapienti cristiani, arabi ed ebrei si riunirono a Toledo su incarico di Alfonso di Castiglia, e stilarono le Tavole Alfonsine, che riguardavano i movimenti del Sole, della Luna e dei pianeti, sempre rispettando il sistema geocentrico di Tolomeo: furono usate fino ai tempi di Keplero.
Il francescano Ruggero Bacone in un’opera intitolata Opus Majus portò a conoscenza del Papa Clemente IV che il calendario non rispettava più la cronologia. Mostrò che l’anno giuliano fissato in 365,25 giorni era più lungo dell’anno tropico, e che si era accumulato un ritardo tale che l’equinozio di primavera fissato al 21 marzo, cadeva ormai il 13 marzo.
Morto Clemente, il problema venne dimenticato per altri 4 secoli.
Ma con il periodo dell’Umanesimo aumentarono le conoscenze scientifiche che provenivano dall’Impero bizantino (grazie anche al cardinale Basilio Bessarione, già arcivescovo di Nicea).
Anche nella Chiesa si comprese che occorreva mettere ordine nel calendario; era tempo di adeguare le date secondo le scienze astronomiche. Le osservazioni astronomiche mostravano che ormai l’Equinozio di Primavera cadeva l’11 marzo anziché il 21 come si era deciso dopo il concilio di Nicea, in accordo con il valore dell’anno tropico delle tavole Alfonsine.
Nel Concilio di Trento (1545), convocato da Paolo III, si diede il via alla riforma del calendario. Nel 1575 Gregorio XIII nominò una commissione costituita da 9 membri, di cui 3 erano astronomi. Uno dei 3 fu Cristoforo Clavio, astronomo del Collegio romano (divenuta poi Università Gregoriana).
Un altro membro era Ignazio Danti, domenicano, che insegnava astronomia e matematica a Bologna dove costruì una meridiana in San Petronio.
Il membro laico era Antonio Lilio, medico e astronomo, fratello di Luigi Lilio, morto qualche anno prima, autore della proposta di riforma al calendario poi adottata. Furono esaminate anche altre proposte come spostare le date in modo da far cominciare l’anno il giorno del Solstizio d’inverno, o fissare l’Equinozio al 25 marzo, oppure variare la lunghezza dei mesi adeguandola al passaggio del Sole nei segni zodiacali).
NUMERI:
- anno giuliano 365,25
- anno siderale (misurato in riferimento alle stelle fisse: 365,25636
- anno tropico (misurato tra due successivi passaggi del Sole per il punto dell’Equinozio di primavera 365,24219 (tavole Alfonsine davano 365,242546) è più breve del tropico per la precessione degli equinozi
- anno anomalistico 365,25964 due passaggi successivi della Terra al perielio (un po’ più lungo del siderale, 11 secondi in più)
- anno civile o gregoriano (365,2425) quel che manca viene recuperato con gli anni bisestili; ci sono 97 anni bisestili ogni 400 anni, invece che 100.
La differenza dall’anno solare è di 26 secondi (in eccesso). Questa discrepanza equivale a circa un giorno ogni 3.323 anni, quindi essendo stato istituito nell’anno 1582 bisognerà sopprimere un giorno nell’anno 4905 per non avere l’equinozio il 20 marzo invece del 21.
Inoltre, in 400 anni gregoriani ci sono esattamente 365 * 303 + 366 * 97 = 146097 giorni. Poiché 146097 è divisibile per 7, anche i giorni della settimana si ripetono uguali dopo 400 anni. Questo vuol dire che i calendari sono esattamente uguali (se non si considera la data della Pasqua): il calendario del 2000 è uguale a quello del 1600 e sarà uguale a quello del 2400, del 2800…
Finchè fu usato il calendario giuliano era facile trovare la data di Pasqua. Bastava il numero d’oro, cioè la posizione che occupa l’anno nel ciclo diciannovennale. In un ciclo di 19 anni le lunazioni si ripetono uguali. Da questo si ricavavano tutte le date dei pleniluni di tutto l’anno. La Pasqua veniva celebrata la prima domenica dopo il plenilunio pasquale, quello che cade tra il 21 marzo e il 18 aprile.
LA RIFORMA GREGORIANA Per recuperare i dieci giorni perduti, si stabilì che il giorno successivo al 4 ottobre 1582 fosse il 15 ottobre anziché il 5. Anche i paesi che adottarono il calendario gregoriano successivamente dovettero stabilire un analogo “salto di giorni” per riallinearsi (vedi i protestanti, la Chiesa d’Oriente).
Per modificare la durata media dell’anno, venne cambiata la regola che decide gli anni bisestili: gli anni la cui numerazione è multipla di 100 sono bisestili soltanto se essa è anche multipla di 400: vale a dire, sono bisestili gli anni 1600, 2000, 2400… mentre non lo sono gli anni 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300…. (Per i secoli precedenti resta valido il calendario giuliano quindi 1500, 1400, 1300… sono bisestili); ci sono 97 anni bisestili ogni 400 anni, invece che 100. La differenza dall’anno solare è di 26 secondi (in eccesso). Questa discrepanza equivale a circa un giorno ogni 3.323 anni, quindi essendo stato istituito nell’anno 1582 bisognerà sopprimere un giorno nell’anno 4905 per non avere l’equinozio il 20 marzo invece del 21. Inoltre, in 400 anni gregoriani ci sono esattamente 365 * 303 + 366 * 97 = 146097 giorni. Poiché 146097 è divisibile per 7, anche i giorni della settimana si ripetono uguali dopo 400 anni. Questo vuol dire che i calendari sono esattamente uguali (se non si considera la data della Pasqua): il calendario del 2000 è uguale a quello del 1600 e sarà uguale a quello del 2400, del 2800…
Con il calendario gregoriano per calcolare la data della Pasqua i conti vengono complicati proprio dal salto di qualche anno bisestile.
Il numero d’oro non è sufficiente e occorre sapere un altro numero: l’epatta
NUMERO D’ORO
II numero d’oro è il numero d’ordine dell’anno nel ciclo diciannovennale, detto ciclo di Metone, (astronomo ateniese V secolo a.C. ) secondo cui si ripetono con buona approssimazione le date dei noviluni. Il numero 1 della successione venne attribuito all’anno 1 a. C.. Il numero d’oro di un qualsiasi anno si ottiene come resto della divisione (numero anno + 1)/ 19 considerando solo la parte intera del numero. Il Numero d’oro consente, nel calendario giuliano, di conoscere le date dei noviluni convenzionali (non quelli effettivi) ottenuti aggiungendo ad una data iniziale alternativamente lunazioni di 29 giorni (mesi cavi) e di 30 giorni (mesi pieni). Per compensare l’imperfezione del ciclo di Metone, si fanno, secondo precise regole, alcune correzioni a quest’alternanza e si anticipa di un giorno l’ultimo novilunio nel 19° anno di ciascun ciclo; operazione questa detta dagli antichi computisti saltus Lunae.
L’EPATTA
età della Luna al 1 gennaio di un dato anno, ossia il numero di giorni trascorsi dall’ultimo novilunio dell’anno precedente.
Nel calendario giuliano le epatte erano 19, e non si consideravano bastando il numero d’oro.
In quello gregoriano la serie di 19 epatte cambia ad ogni equazione solare diminuendo o aumentando (equazione lunare) di una unità. Se sono contemporanee si elidono (equazione solare si verifica per l’omissione del bisestile ogni 400 anni, l’equazione lunare si verifica per l’aumento dell’età della Luna stabilita da Lilio per correggere il ciclo di Metone). L’età della Luna viene diminuita di un giorno ad ogni equazione solare, ed aumentata di un giorno ogni equazione lunare.
Il nome deriva dal greco epaktos, importato, venuto di fuori, perchè questi giorni, importati dall’anno precedente, servono a calcolare le date dei noviluni per tutto l’anno. Poiché la lunazione ecclesiastica dura o 29 o 30 giorni, l’epatta è un numero compreso fra 1 e 30 che viene indicato con cifre romane. Per il calcolo dell’epatta ci sono vari metodi, da consultare qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_della_Pasqua
Essendo la Pasqua determinata in parte facendo riferimento al ciclo solare annuale (Equinozio primaverile) ed in parte al ciclo lunare (plenilunio) la sua mobilità non è illimitata ma esistono due date estreme al di fuori delle quali la Pasqua non può mai cadere.
La data della Pasqua è compresa tra il 22 marzo (Pasqua bassa) ed il 25 aprile (Pasqua alta). Infatti, se proprio il 21 marzo è luna piena, e questo giorno è sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22 marzo); se invece è domenica, il giorno di Pasqua sarà la domenica successiva (28 marzo). D’altro canto, se il plenilunio succede il 20 marzo, quello successivo si verificherà il 18 aprile, e se questo giorno fosse per caso una domenica occorrerebbe aspettare la domenica successiva, cioè il 25 aprile.
COME SI CALCOLA LA DATA DELLA PASQUA
| anno : 19 = | - | resto a |
| anno : 100 = | b | resto c |
| b : 4 = | d | resto e |
| (b + 8 ) : 25 = | f | - |
| (b - f + 1) : 3 | g | - |
| (19 x a + b - d - g + 15) : 30 = | - | resto h |
| c : 4 = | i | resto k |
| [32 + (2 x e) + (2 x i) - h - k] : 7 = | - | resto L |
| [a + (11 x h) + (22 x L)] : 451 = | m | - |
| [h + L - (7 x m) + 114] : 31 = | n | resto p |
n sarà il numero del mese (3=marzo 4=aprile)
p +1 è il giorno di Pasqua
Ultime precisazioni sulle regole ecclesiastiche:
Il calcolo della data della Pasqua è legato a dati astronomici veri, ma, oltre la storia raccontata precedentemente ci sono ancora degli elementi di cui occorre tenere conto:
- si considera un periodo sinodico costante, quando si sa che risulta sensibilmente variabile da un giro orbitale all’altro
- si segue una regola per per stabilire la fase lunare anche per tempi passati e futuri molto lontani senza ricorrere a calcoli astronomici: a Chiesa ritenne di dover stabilire regole facili da seguire anche da chi fosse stato digiuno di astronomia.
- altri piccoli aggiustamenti.
Il risultato che se ne ricava è la Luna del computo, che non corrisponde alla Luna vera.
Lo scostamento tra le due Lune può arrivare fino a 3 giorni in più o a uno in meno.
Si presume poi che la Luna si renda visibile a occhio nudo circa 30 ore dopo la congiunzione con il Sole e a questo momento si fa risalire la Luna nuova; per quanto riguarda il plenilunio si prende in considerazione che si verifichi 13 giorni dopo la Luna nuova (in realtà trascorrono 14,7 giorni, ma in questo modo si compensa l’”errore” delle 30 ore.
Al tempo della riforma si stabilì di diminuire di un giorno l’età della Luna per evitare che il plenilunio del computo non cadesse mai prima di quello astronomico.
CURIOSITA’
- in un ciclo di 5.700.000 anni la Pasqua viene il 23 marzo (come nel 2008) 54.150 volte
- La precedente Pasqua al 23 marzo risale al 1913 tornerà nel 2160
- La Pasqua più bassa (22 marzo) viene in media (ma con grandi scarti) una volta ogni 207 anni, si è verificata nel 1818 e tornerà nel 2285
- La Pasqua più alta, il 25 aprile, viene in media una volta ogni 136 anni, l’ultima volta è venuta nel 1943, tornerà nel 2038.
- Pasqua ortodossa (14 aprile 2008 per il calendario giuliano)
- Pasqua ebraica (15 Nissàn 5768 per il calendario ebraico) domenica 20 – 21 aprile 2008 (inizia mezz’ora dopo il tramonto)
Nei secoli passati potevano esistere diversi usi locali sulla data da seguire, tutti comunque legati al calcolo della Pasqua ebraica (Pesach in ebraico significa Passaggio, Esodo), con cui è in stretta relazione.
PESACH O PESAH
Inizia il 15 del mese di Nissan e termina il 22 dello stesso mese.
- 2005 - 24 aprile (15 nissan 5765)
2006 -13 aprile (15 nissan 5766)
2007 - 3 aprile (15 nissan 5767)
2008 - 20 aprile (15 nissan 5768)
2009 - 9 aprile (15 nissan 5769)
2010 - 30 marzo (15 nissan 5770)
2011 - 19 aprile (15 nissan 5771)
2012 - 7 aprile (15 nissan 5772)
2013 - 26 marzo (15 nissan 5773)
La Pasqua ebraica si celebra in ricordo dell’uscita degli Ebrei dall’Egitto.
Nissan è il settimo mese del calendario ebraico secondo il computo ordinario. È invece il primo mese secondo il computo dall’uscita dall’Egitto o l’ottavo mese nel computo ordinario negli anni embolismici.
Il calendario ebraico è basato sul ciclo metonico di 19 anni divisi tra normali (peshutim) ed embolismici (meubbarim) nei quali viene aggiunto un tredicesimo mese. Gli anni embolismici sono il 3°, il 6°, l’ 8°. l’11°, il 14°, il 17° ed il 19° anno del ciclo. Se ne ricava che il ciclo è composto di 12 anni di 12 mesi (144 mesi) e da sette anni di 13 (91 mesi) per un complessivo di 235 mesi lunari. Il tredicesimo mese si chiama Adar Sheni.
Il mese lunare dura circa 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi (il valore usato per i calcoli è 29 giorni, 12 ore e 793/1080 di ora, con uno scarto di pochi decimi di secondo). L’anno solare, invece, dura circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Da questo deriva che nell’arco di un anno il calendario lunare di 12 mesi resta indietro di circa 10 giorni e 21 ore rispetto a quello solare. Alternando anni di 12 e 13 mesi come specificato, però, si riesce a compensare quasi esattamente la differenza: lo scarto tra 19 anni solari e 235 mesi lunari è appena di 2 ore e 5 minuti circa, pari a circa 7 minuti per anno.
Oggi si sa che la velocità della Luna è in continuo, anche se infinitesimale, aumento con una conseguente riduzione del periodo lunare: questo introduce un’ulteriore fonte di errore.
FONTI: Wikipedia e Almanacco UAI
L’Equinozio
I nostri progenitori devono aver notato, nello scorrere di un ciclo stagionale, che si verificavano 4 eventi particolari riguardanti il Sole, quell’oggetto luminoso a cui era inevitabile attribuire il calore e la luce che rende gradevole l’esistenza. Per due volte avranno notato che giorno e notte avevano la stessa durata, per una volta che un certo giorno la notte era così lunga da dare l’impressione di non finire mai, e per un’altra volta era il giorno a durare molto tempo. Osservando attentamente di anno in anno uomini particolarmente attenti avranno notato che il Sole, che sembrava abbassarsi sempre più nell’arco che percorreva ogni giorno, riprendeva a salire sull’orizzonte, e che in certi periodi la temperatura diventava più gradevole e la natura riprendeva vigore e sviluppo. Valeva la pena esprimere la propria gioia.
Ecco individuati 4 punti sulla “strada” che il Sole sembrava percorrere, chiamata poi Zodiaco (cerchio di animali), dove sullo sfondo dovevano esserci dei gruppi di stelle che ricordavano delle figure famigliari… i loro animali addomesticati, l’ariete, il toro, o altre figure tra l’immaginario e il reale.
Nello scorrere dei millenni a causa della precessione degli equinozi, altri 8 punti sono stati individuati, portando questi segni a 12.
Intorno a questi 4 giorni da tempi immemorabili si fanno feste, riti e cerimonie. Anche la Pasqua fa parte di queste feste, le feste dell’Equinozio. Parleremo in altra pagina delle feste nella storia e nel mondo.
Il punto in cui il Sole attraversa l’Equatore celeste* dal Sud al Nord segna l’Equinozio (dal latino aequa nox) di primavera.
 |
|
|
|
Equinozio
|
Solstizio
|
Per calcolare la durata con la massima precisione si specifica che l’alba inizia quando il Sole ha superato l’orizzonte per la sua metà e il tramonto quando il sole è scomparso per metà sotto l’orizzonte.
All’equinozio il giorno e la notte durano 12 ore.
Negli equinozi il Sole, per restare in tema di Passaggio (ecco il legame con la Pasqua che significa passaggio) attraversa l’equatore celeste nei punti corrispondenti all’equinozio di primavera intorno al 21 di Marzo e di autunno, intorno al 23 di Settembre. Il punto corrispondente all’equinozio di primavera si chiama punto vernale, oppure punto d’Ariete. Il richiamo all’Ariete è dovuto al fatto che anticamente in questa data il Sole si proiettava sulla costellazione omonima. Oggi, per effetto della precessione degli equinozi, si trova nella costellazione dei Pesci (precisiamo che stiamo parlando di costellazioni, non di segni zodiacali, che riguardano altro dall’astronomia). Si sposterà poi nell’Acquario.
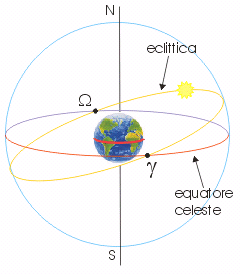
*L’equatore celeste è la proiezione dell’equatore terrestre sulla sfera celeste.
L’asse di rotazione della Terra è inclinato rispetto al piano dell’orbita, l’equatore celeste è inclinato rispetto all’eclittica.
L’eclittica è il cerchio proiettato sulla sfera celeste che apparentemente compie il Sole (in effetti invece è la Terra che gira intorno al Sole) in un anno.
Anche gli altri pianeti visibili ad occhio nudo come Venere, Marte e Saturno, sembrano muoversi lungo l’eclittica poiché le loro orbite sono su un piano simile a quello della Terra. L’eclittica si sovrappone alla fascia dello Zodiaco.
Entries and comments feeds.
Valid XHTML and CSS. ^Top^
14 queries. 0.105 seconds.
Powered by WordPress with jd-sky theme design by John Doe.
